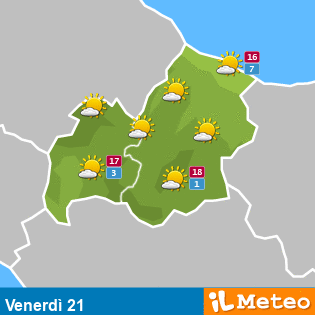Due poesie, due registri espressivi profondamente diversi, un’unica tensione morale che le attraversa come un filo invisibile. I componimenti che seguono, entrambi già editi e tratti da sillogi differenti, rappresentano due momenti distinti ma complementari del percorso poetico di Yari Lepre Marrani, autore capace di muoversi con naturalezza tra introspezione esistenziale e rievocazione storico-epica.
Nel primo testo, lo sguardo si rivolge all’interno. La poesia si fa specchio – infedele, inquieto, mai neutrale – e diventa strumento di riflessione sulla vecchiaia, sull’identità e sul rapporto tormentato tra ciò che appare e ciò che realmente abita il cuore dell’uomo. È un dialogo serrato con il tempo che passa, con le ferite lasciate dalla vita, ma anche con la dignità e la bellezza che resistono oltre il dolore. Un canto intimo, teso, attraversato da immagini forti, in cui la lotta è tutta interiore.
Di tutt’altra natura, ma non meno intensa, è la seconda lirica: una lunga e articolata confessione poetica affidata alla voce di Annibale Barca. Qui la poesia assume i toni del monologo tragico e storico, in cui il grande condottiero cartaginese, ormai giunto al termine della sua esistenza, ripercorre le proprie imprese, le ossessioni, le sconfitte e i rimpianti. L’eroe diventa uomo, il mito si incrina, lasciando emergere una malinconia profonda, quasi romantica, che trasforma la gloria in peso e l’ambizione in condanna.
Due testi lontani per ambientazione e forma, eppure uniti da una medesima interrogazione sul destino umano, sul tempo, sulla memoria e sul senso ultimo delle scelte compiute. È in questo spazio comune, fatto di coscienza, rimpianto e consapevolezza, che le due liriche dialogano tra loro, offrendo al lettore una riflessione intensa e stratificata sulla fragilità dell’uomo, sia esso anonimo di fronte allo specchio o gigante della Storia.
1) Lo specchio infedele
Cerco uno specchio dai mille riflessi
che onestamente mi restituisca
la mia immagine reale
senza dover chiedere ai misteri
di non mostrarmi vecchio quando ancor
son giovane o abbruttire il mio volto
per far piacere a chi dietro lo specchio si cela.
Il mio ritratto non è mai stato dipinto
e non so se il pittore mancato
sarebbe più onesto di uno specchio
nel fissare su tela le verità del mio volto:
verità imbrunite dalle croci della vita
ma incapaci di tramutare vigori in rughe
di dolore.
Giunto al meridiano della mia vita
non posso accettare che uno specchio infedele
mi getti in un equatore rovente dove
un pozzo d’acqua infetta toglierà dal mio viso
gli ultimi riflessi del mio coraggio
per gettarli in una fornace ardente.
Frantumerò quel vetro fetente
che distorce il mio volto
senza chiedermi il permesso
di stare di fronte a me
e mostrarmi i dolori che ho tenacemente superato
e la bellezza che ancor possiedo.
Poesia edita tratta da “I canti di un pellegrino”(Booksprint Editore, 2024)
2) Annibale Barca
Folle e ardimentoso
sin dalla guerriera fanciullezza,
fui strumento dell’odio e delle sue spire un principe
rancoroso
quando dal padre mio, Amilcare, mio tentatore,
lanciai al devastato mondo
il mio grido di battaglia
e dell’eterna città, Roma,
ambii a cogliere l’eterna medaglia.
Fanciullo tra i fragori della guerra, dei campi di battaglia,
miei secondi padri e mie dilette madri,
videro i miei occhi infuocati le polverose strade,
gli eserciti all’assalto ed ecco Amilcare,
tentatore, farmi luce sul loro oscuro risalto.
Perché se d’odio e sterminio
fui il figlio prediletto e satanico portatore,
ormai stanco, sotto l’occhio di Prusia,
mi chiudo nel mio letto
e con il tradimento di un povero Re
mi lancio nell’ultimo grido
che della mia furiosa vita è stato compagno e amico:
“Roma tu sarai mia o non sarai!”.
Parole che dovevan far tremare il mondo
e più non sono che grida ai quattro venti,
rabbiosa invettiva di un vecchio guerriero
che sta per liberarsi, nell’esilio odiato,
del suo ultimo fardello: la vita!
Quale atroce tormento è il morire
senza averla vista perire,
lei,
la città eterna, odiate mura
che non seppi superare
io, il selvaggio e il tormentatore,
che Roma non sapeva amare.
Solitaria polvere al vento presto diverrò
ma nessuno negherà ciò
che sono stato e che sarò,
in eterno, finché dalla terra germoglierà
dei conquistatori di regni e imperi il seme bellico
e se non vedrò Roma sconfitta e umiliata,
ultima speme, orgoglioso innanzi alla Storia
mi diletto per non averla mai amata,
io che feci dell’odio e della guerra
la scintilla fiammeggiante
che volevo mi portasse sul podio
degli immortali vincitori.
E la carnefice gloria di poche battaglie
rende più sereno il mio cuore,
ma adesso esso duole
perché il tempo della vita è fuggito,
come un serpente che scompare nella roccia,
ed eccomi annebbiato dal dolore di aver perso
per sempre il mio furore,
che ieri fece tremare il cielo terso
e le pianure italiche scioccate,
invase e straziate da un uomo unico e diverso.
La mano che fece tremare il mondo cade adesso
sul mio petto finito, in un vincolo perverso.
Giurai odio e l’odio raccolsi
quando le mie eterne vittorie colsi,
lontano dalla patria, quando a Canne li travolsi,
odiati romani,
che volevo stringere
tra le mie barbare mani.
Ambizione e orgoglio
guidarono la mia avventura quando, valicando le Alpi,
giunsi a toccar l’odiato suolo.
Di allora non resta che un ricordo di terrore
in quest’ora di sventura.
Quale fardello devo sopportare, io,
meraviglia della natura,
se dalle Alpi solo morte e distruzione seppi portare
e lei rimase ferma, mio sogno e mia prigione,
e quelle mura invalicabili non seppi divorare
ma, mute e ferme, a dileggiarmi dall’alto rimasero,
quelle mura… protagoniste dei miei sogni più implacabili.
“Guerriero” mi fu detto, “tu non sai sfruttare le vittorie!”
mai verità fu pronunciata con più pura sincerità!
Eccomi, ora, dannato all’oblio dell’esilio e della morte,
perché dalla gloria felice di quelle battaglie
non seppi vincer l’ultima, la più agognata:
la conquista di Roma tanto odiata.
Opprime il mio capo la vecchiaia temuta
e l’ambizione e l’orgoglio,
che guidarono la mia avventura,
sono tramontati in quest’ora di sventura.
Feroce conquistatore venuto dalle Alpi
sei svanito nella tempesta della Storia,
ai posteri porgi il lascito
della tua disumana superbia!
Ed ecco la memoria dolorosa che,
avvicinatasi all’orecchio,
assilla le mie stanche membra e mi sospira
“Imilce, Imilce, sono la tua Imilce, abbandonata
al destino del delirio di un guerriero!”
E la voce continua, tenue, con un sospiro foriero
di un’angoscia ancor più grande:
“Sono il tuo unico figlio, tuo e di Imilce,
da Cartagine ti saluto,
saluto quel padre che mai ho veduto!”
A questo delicato sussurro all’orecchio,
che altro non è se non della coscienza
un pallido e lontano rigurgito, la mente,
un tempo fulminea, e il corpo la cui mano,
allora, indicò furiosa l’odiata meta,
crollano nella funerea stanza della morte.
“Imilce, e tu, figlio mio… dove siete?” grida la mia voce
che sul suolo italico seppe dimostrare
la volontà più truce!
Cartagine mi ha perduto.
Didone, immortale tra i purpurei cieli,
soffia, piangente, sul mio corpo canuto.
Ieri ero virtù, scettro e potenza di Gloria,
l’ozioso tempo della sconfitta la mia tempra ha adombrato
esco, umiliato e sconfitto, dal maestoso teatro della Storia
che sempre dimentica chi da essa è stato annullato.
L’emozione scuote, adesso, il mio cuore debole
per ciò che poteva esser più grande ma non è stato!
Risorgere nell’orgoglio e nell’ambizione
non è ciò che voglio: ferma è l’intenzione
di sparire dalla gente e la ferocia,
che ieri insanguinò pianure e città oggi tace,
svanisce innanzi al vecchio stanco che vuole solo pace.
L’orgoglio mi fece un conquistatore spietato
e la vecchiaia e i ricordi m’infiammano,
in quest’ora morente,
del sogno perduto di poter cambiare
il corso della Storia.
Vergogna e rimpianto:
questi i demoni che accolgono il mio pianto,
lasciata dietro
la folgore tempestosa e la divina energia
che negli anni bellicosi mi mostrò l’ambiziosa via.
E Roma è in piedi e io seduto,
vecchio e sperduto
in questa casa senza nome,
ultimo rifugio delle mie membra
che al nemico non darò.
In questa notte pioverà su Roma
e il cielo ricoprirà la sua regale chioma
con lo spirito dei miei compagni morti.
Tutto è finito e io, uomo
che non si credeva terreno,
ma audace, astuto e superiore,
muoio qui con il mio fatal veleno.
Poesia edita tratta dalla silloge “Quel sentiero in mezzo al bosco”, 2022