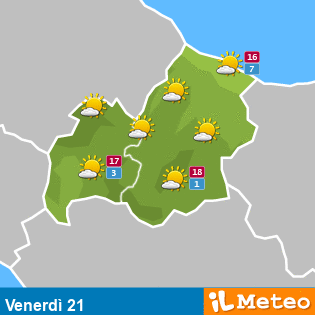Dal libro alla docu-serie, fino alla serie tv. È questo il percorso di “Sarah. La ragazza di Avetrana”, il libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni (pubblicato da Fandango).
Dopo il grande successo editoriale dell’opera, che rilegge in maniera critica il tristemente noto delitto di Avetrana ponendo un particolare accento sul peso mediatico che ha avuto quel caso, e dopo la docu-serie andata in onda su Sky e per la quale Piccinni e Gazzanni sono stati gli autori, ora arriva un nuovo importante traguardo. Prossimamente sarà visibile sulla piattaforma Disney+ “Qui non è Hollywood”, la serie tv  ispirata al libro della coppia che ha scelto Lucca come punto fermo – una base fra i numerosi impegni da autori e conduttori per Rai1 e Rai2 –, ma che adora il Molise e qui torna spesso, essendo Gazzanni nato a Isernia. Il lavoro, con la regia di Pippo Mezzapesa (a breve al cinema con un’altra opera d’autore, Ti mangio il cuore, film sulla mafia foggiana con protagonista Elodie e che sarà presentato anche al Festival di Venezia) e che vede alla scrittura “pezzi da novanta” del panorama della sceneggiatura italiana come Antonella Gaeta e Davide Serino, si focalizzerà in quattro puntate proprio sull’omicidio di Sarah Scazzi, che viene narrato in maniera inedita tenendo sempre a mente il peso mediatico che ha caratterizzato il caso.
ispirata al libro della coppia che ha scelto Lucca come punto fermo – una base fra i numerosi impegni da autori e conduttori per Rai1 e Rai2 –, ma che adora il Molise e qui torna spesso, essendo Gazzanni nato a Isernia. Il lavoro, con la regia di Pippo Mezzapesa (a breve al cinema con un’altra opera d’autore, Ti mangio il cuore, film sulla mafia foggiana con protagonista Elodie e che sarà presentato anche al Festival di Venezia) e che vede alla scrittura “pezzi da novanta” del panorama della sceneggiatura italiana come Antonella Gaeta e Davide Serino, si focalizzerà in quattro puntate proprio sull’omicidio di Sarah Scazzi, che viene narrato in maniera inedita tenendo sempre a mente il peso mediatico che ha caratterizzato il caso.
Per adesso si sa ancora molto poco: le selezioni sono in corso, le prime riprese cominceranno a fine mese e nel cast ci sarà, tra gli altri, la talentuosa attrice pugliese Vanessa Scalera, che si è distinta nella fiction Rai Imma Tataranni. La serie sarà prodotta dalla società Groenlandia e da Matteo Rovere, acclamato regista del film Il primo Re, che ha comprato i diritti del romanzo per sviluppare prima la docu-serie e ora, appunto, la serie tv. «È una sfida anche per noi molto importante – spiega Gazzanni che, con Flavia Piccinni, ha lavorato al soggetto di serie oltre ad aver seguito per intero i lavori di scrittura e di sceneggiatura – L’obiettivo è far emergere la distorsione della narrazione televisiva, avvalendoci proprio di quello strumento, la televisione, nella sua forma più lontana dal reale come può essere la fiction».
Una sfida impegnativa. Avendo seguito e letto le sceneggiature, credi di aver raggiunto il risultato?
«Vedremo. Certamente il lavoro portato avanti dagli sceneggiatori, dal regista ma anche dal produttore Matteo Rovere, è molto valido e già adesso noi siamo soddisfatti. Poi, com’è giusto che sia, dovranno essere i telespettatori ad esprimere un giudizio. Quello che ci auguriamo è che la serie tv, più che dare risposte, possa interrogare il telespettatore. Non tanto – o non solo – su chi ha ucciso Sarah Scazzi, quanto sul peso mediatico dell’intera vicenda».
Il titolo non è casuale: “Qui non è Hollywood”…
«Diciamo che il titolo è venuto quasi spontaneo. D’altronde è una citazione presente anche nel libro. Ricordo quando siamo andati io e Flavia la prima volta ad Avetrana. Era l’estate del 2019 (il libro è stato pubblicato nel 2020, ndr) e ci siamo finti avvocati per parlare con più persone possibile e per entrare in alcuni luoghi che altrimenti ci sarebbero rimasti preclusi. Immediatamente siamo rimasti colpiti da un murales che ancora campeggia nel paesino salentino e che risaliva proprio al periodo dell’omicidio di Sarah Scazzi: era un modo come un altro, forse inconscio e inconsapevole, per dire alle tante troupe presenti al tempo dell’omicidio che la realtà si stava trasformando in uno show, che quello che si stava raccontando non sempre corrispondeva alla verità dei fatti. Questo elemento, profondamente presente nel documentario, avrà uno spazio centrale anche nella serie tv».
Qual è stato il ruolo mediatico del caso Scazzi?
«Il caso Scazzi rappresenta una sorta di punto di non ritorno, perché se da una parte già c’erano stati racconti di cronaca nera della cosiddetta “tv del dolore” – penso soprattutto ad Alfredino Rampi e a Vermicino –, con il delitto di Avetrana si fa un passo ulteriore, perché per la prima volta il 6 ottobre 2010 alla mamma di Sarah, Concetta Serrano, viene comunicato in diretta, dopo 42 giorni di ricerca, che la figlia non è scomparsa, bensì è morta e che a uccidere la figlia sarebbe stato – secondo quello che si disse all’epoca – lo zio di Sarah, Michele Misseri. Quell’episodio è emblematico perché rappresenta un momento in cui tutto sembra diventare legittimo. Diventa legittimo concentrarsi sul morboso, diventa legittimo invadere un paese e intervistare chicchessia semplicemente per avere “qualcosa” da dire nel corso delle innumerevoli dirette diventate un appuntamento fisso per la televisione italiana. Diventa legittimo spiare dal buco della serratura e raccontare fatti privati che magari nulla c’entrano con l’inchiesta per omicidio. In sintesi, Avetrana è stata una lente di ingrandimento sul cinismo dei giornalisti e degli autori televisivi, ma ancora di più sul voyeurismo macabro di noi telespettatori».
Quando avete pubblicato il libro pensavate che potesse diventare la sceneggiatura di un lavoro video?
«No, assolutamente. Quando l’abbiamo saputo siamo stati annientati dal senso di responsabilità che avevamo, e che tutt’oggi percepiamo, nei confronti dei familiari di Sarah Scazzi e della famiglia Misseri. Abbiamo cercato di affidare prima alla docu-serie e poi alla serie tv una visione imparziale sul delitto, il cui processo indiziario ha portato all’arresto di tre persone. Due delle quali, Sabrina Misseri e Cosima Serrano, sono condannate all’ergastolo e continuano a dirsi innocenti. E uno, Michele Misseri, seguita a dirsi colpevole ed è prossimo alla scarcerazione».
Sicuramente tener fede a questo proposito è ancora più complicato in un racconto “fiction”.
«Assolutamente sì. Ed è, come dicevo prima, la vera sfida: provare a condannare un modo di fare televisione con lo strumento più lontano dal reale com’è quello della serie tv. Io e Flavia cerchiamo sempre di alzare la nostra personale asticella: i casi di cui ci occupiamo, le inchieste che realizziamo, sono tutte mirate a porre degli interrogativi più ampi del caso specifico, come se volessimo passare, in una chiave quasi filosofica e antropologica, dal “particolare” all’”universale”. E sono interrogativi che ovviamente poniamo innanzitutto a noi e, se riusciamo, anche a chi ci ascolta, ci legge e, come in questo caso, ci vede o ci vedrà».
Ci sono altri progetti su cui stai lavorando?
«Ce ne sono tanti. A breve ricomincerà la stagione invernale in Rai e lavorerò, come autore e inviato, in alcuni programmi in prima serata di inchiesta e approfondimento, senza mai abbandonare i programmi di racconto del territorio».
Come Linea Verde Life.
«Esatto. Più che un semplice programma definirei Linea Verde Life una vera e propria famiglia con due grandi conduttori (Marcello Masi e Daniela Ferolla, ndr). È un onore lavorare con loro, con i registi e con tutti gli altri autori del programma. Ogni volta che sono in giro o preparo una puntata, ho la netta sensazione che si sta facendo del vero servizio pubblico. E, devo dire, è davvero una bella sensazione».
Ma non c’è solo la Rai.
«No. Sempre con Flavia sto lavorando a nuovi documentari per le piattaforme».
C’è anche un podcast, se non sbaglio, in uscita.
«Sì. Rientra sempre nella necessità di sperimentare, creare, sfruttare nuovi strumenti narrativi per raccontare il reale. Stiamo lavorando ormai da mesi a un podcast, un audio-documentario in otto puntate sul Forteto, una delle organizzazioni settarie di cui ci siamo occupati nel nostro primo libro scritto insieme (Nella setta, Fandango Editore, 2018). Il tema è di stringente attualità, considerando che è in corso anche una commissione d’inchiesta parlamentare su quanto accaduto in quella comunità».
Puoi anticiparci qualcosa?
«È una storia incredibile, drammatica. Che si conosce ancora troppo poco. Parliamo di una vera e propria comunità dell’orrore, nata nel 1978 nel Mugello, in Toscana. Qui anche i minori venivano fatti lavorare, maltrattati e abusati da Rodolfo Fiesoli, un uomo oggi condannato e in carcere e che al tempo si faceva chiamare “Il Profeta”. Ciò che stupisce del Forteto è che parliamo di una storia durata oltre trent’anni, dato che l’inchiesta scoppia solo nel 2011. Tutti conoscevano il Forteto e tutti – istituzioni in primis – ritenevano fosse una sorta di paradiso in terra, messo su da un uomo che aveva semplicemente ideato un sistema pedagogico alternativo. E così il Tribunale dei Minori, tanto per dire, per anni ha mandato in affidamento minori provenienti da famiglie disagiate o violente, non rendendosi conto che quel luogo era la definitiva perdizione e non una salvezza. Con l’aggravante che il Forteto è sempre stata una cooperativa agricola, mai una comunità per minori. Ma qualcuno, si vede, ha chiuso un occhio. O forse entrambi. Le storie che stiamo raccogliendo di vittime, fuoriusciti, ragazzi scappati sono drammatiche e scioccanti».
Perché avete scelto proprio questa storia?
«Anche in questo caso ciò che interessa me e Flavia è interrogare chi in questo caso ascolterà il podcast. A che punto può arrivare la manipolazione mentale? E, ancora, è “meno vittima” delle altre chi, oggi fuoriuscito dalla setta, ha commesso anche lui maltrattamenti e violenze semplicemente perché era plagiato e credeva negli “insegnamenti” di Fiesoli? O è da considerare anche lui un carnefice? Qual è il confine – se c’è – tra vittima e carnefice in una setta, in un’organizzazione in cui tutti gli “ingranaggi” devono necessariamente obbedire al guru in maniera acritica per non rischiare violenze, percosse e maltrattamenti? Ecco, queste sono le domande che ci stiamo ponendo io e Flavia e che ci piacerebbe rivolgere, tramite l’audio-documentario cui stiamo lavorando, anche a chi vorrà sentire il podcast».
Dall’audio al video, dal podcast alla serie tv, dunque, sempre con lo stesso intento: interrogare chi ascolta o vede o legge il racconto.
«Credo che un narratore, qualunque forma abbia il suo racconto, non debba mai fornire delle risposte belle e impacchettate. Significherebbe pretendere dal lettore un atteggiamento acritico. E invece bisogna porre delle domande che stuzzicano la curiosità di chi ci è di fronte. Magari lo porteranno alle nostre stesse conclusioni, o magari in tutt’altra direzione, come ci è capitato in diversi libri cui abbiamo lavorato io e Flavia. È il bello del confronto dialettico».
Carmine, ultima domanda sul Molise. Come vedi oggi la nostra regione?
«Sono rimasto felicemente sorpreso quando, a maggio, ho lavorato da autore a una puntata di Linea Verde Life sulla “mia” Isernia: abbiamo raccontato diversi progetti e iniziative che vanno nella direzione della sostenibilità e dell’innovazione. È stata una puntata che mi ha emozionato, anche per gli ottimi risultati di ascolto che abbiamo ottenuto (è stata la seconda puntata dell’intera stagione a raccogliere più ascolti superando il 20% di share, ndr). Credo che tanto ancora ci sia da fare, ma ci sono esperienze nuove che, al di là del colore politico di ognuno, sono estremamente lodevoli. Penso alla giovane amministrazione della mia città che da subito si è distinta per le politiche sociali, per le battaglie portate avanti, per i progetti europei presentati e vinti. E, soprattutto, per i programmi culturali e di partecipazione collettiva che mancavano forse da troppo tempo in città. È una bella sensazione sapere che c’è ancora speranza».
ppm