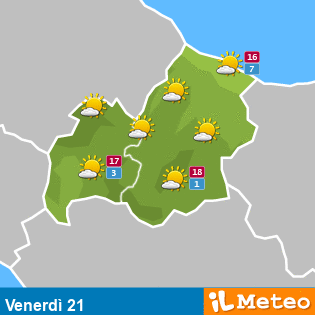L’antica arte della panificazione, ad Agnone, porta il nome dei Patriarca. Una tradizione che si tramanda di generazione in generazione la quale ha fatto del forno nel rione di Sant’Antonio un punto di riferimento per i residenti di tutto il territorio. A caratterizzare la produzione a conduzione familiare, non solo pane ma anche dolci ormai rinomati su scala nazionale che hanno portato il forno ‘Antichi Sapori’ a ricevere importanti riconoscimenti, su tutti quello della famosa guida enogastronomica il ‘Gambero Rosso’. Tuttavia la soddisfazione maggiore per Antonino, poliedrico titolare dell’attività insieme alla moglie Adriana, è quella che quotidianamente gli attribuiscono i clienti sulla bontà dei prodotti sfornati alle prime luci dell’alba. Lavoro duro ma al tempo stesso foriero di compiacimento. Con il gigante di oltre due metri,  padre del pallavolista Stefano, abbiamo voluto ripercorrere le tappe salienti di una storia fatta di passione, sacrificio, abnegazione, qualità e tanto amore intervallata da poesie, dialetto, radio e rappresentazioni teatrali.
padre del pallavolista Stefano, abbiamo voluto ripercorrere le tappe salienti di una storia fatta di passione, sacrificio, abnegazione, qualità e tanto amore intervallata da poesie, dialetto, radio e rappresentazioni teatrali.
Antonino, la tua è una famiglia agnonese da sempre.
«Da quasi tre secoli. I Patriarca erano un gruppo di nomadi, provenienti da Venezia, che era sede dell’autorità ecclesiastica del Patriarcato. Erano una popolazione nomade che si spostava in gruppo, costituita da artigiani, carbonai, commercianti di carbone e di cavalli. Nel 1734 un contingente di 700-800 persone giunse a Miranda e da lì alcuni raggiunsero Isola Liri, gli altri Agnone, dove si insediarono».
Anche il tuo panificio ha radici storiche.
«Il forno aprì nel quartiere Maiella agli inizi del ‘900, avviato da mia nonna. All’epoca quello del fornaio era un lavoro da donna. Nel 1942 ci siamo trasferiti nella sede attuale».
Cosa è cambiato da allora nella panificazione?
«Ai tempi di mia nonna si vendeva poco pane, piuttosto si cuoceva per gli altri. Le cose andavano così: le cosiddette compagne panificavano nella propria abitazione e portavano al forno la pagnotta da cuocere. Dato che non c’era un orario fisso tutte le notti mia nonna e poi mia madre passavano per le case delle compagne prenotate per l’infornata e comunicavano con una specie di alfabeto morse. Un colpo di battocchio significava “ammassa” (impasta), due colpi “funn” (forma). L’impasto si faceva con lievito madre, adesso così di moda. Nonna cercava di favorire le donne della campagna perché sapeva che, dopo la notte passata a fare il pane dovevano andare a piedi e di buon mattino a lavorare la terra. Il più delle volte la cottura del pane, in forno a legna, veniva ricompensata con un baratto a base di olio, grano, patate, frutta. Le forme di pane erano molto grandi, di 4-5 chili, per essere meglio conservate dentro le casse di legno dette cassapani. Con la pasta residua messa al forno si faceva ‘ru susill’ una specie di pizza che veniva fatta assaggiare ai bambini o, il più delle volte, regatato ai più bisognosi. ‘Ru susill’, assieme ai residui dei carboni per scaldarsi, permisero di aiutare durante la guerra gli sfollati di Capracotta, che parlano nei loro libri di memorie della nostra accoglienza ed ancora oggi ci serbano gratitudine».
messa al forno si faceva ‘ru susill’ una specie di pizza che veniva fatta assaggiare ai bambini o, il più delle volte, regatato ai più bisognosi. ‘Ru susill’, assieme ai residui dei carboni per scaldarsi, permisero di aiutare durante la guerra gli sfollati di Capracotta, che parlano nei loro libri di memorie della nostra accoglienza ed ancora oggi ci serbano gratitudine».
Quando è nato il forno come lo conosciamo oggi?
«Essenzialmente quando, per il dovere di emettere scontrini fiscali, non è stato più possibile panificare per altri. Non era possibile dimostrare, in un eventuale controllo, la provenienza pagnotta che usciva dal forno. Del forno abbiamo cominciato ad occuparci direttamente papà e mio fratello Stefano ed io nel 1987. Fino al 1992 il forno è rimasto a legna. Ho sempre cercato di mantenere le caratteristiche del pane fatto da mia nonna (Concettina) e da mamma Filomena, detta Memena. La sua specialità erano i dolci della tradizione, a cominciare dalla castagna al cioccolato, la loffa di Sant’Antonio ed i raffaiuoli, di cui non ha mai voluto dare a nessuno la ricetta».
I tuoi maestri?
«Naturalmente papà (Pasquale), la sorella zia Ada, ma soprattutto mamma, che mi ha insegnato ad amare e rispettare il valore del pane. Rabbrividisco quando mi chiedono il pane già tagliato. È bellissimo sentire lo scricchiolio della crosta, i rumori ed i profumi che si sprigionano».
È stato un destino segnato il tuo?
«Ho cominciato a lavorare presto, a 14 anni, ma ho continuato a studiare e dopo il diploma da perito elettrotecnico ho frequentato la facoltà di giurisprudenza a Roma per un paio di anni. Sono stato costretto a lasciare gli studi dopo una tragedia, la morte improvvisa di mio fratello Stefano, un ragazzone lavoratore estroverso, generoso, benvoluto da tutti che di fatto tirava avanti il forno e lasciò a soli 31 anni di vita la moglie Fausta, puericultrice in pediatria e la piccola figlia Filomena. In ogni caso se mi fossi laureato lo avrei fatto più per dare una soddisfazione ai miei genitori, ma alla fine per libera scelta e senza alcuna costrizione avrei fatto comunque il fornaio».
Vivevi in un quartiere affollato da attività artigianali e commerciali, comprese le botteghe dei funai e la farmacia di don Serafino.
«È lì che è nato il mio amore per le tradizioni ed il dialetto. Avendo tra i clienti soprattutto gente di campagna c’era anzitutto la necessità di capire quello che dicevano, e spesso parlavano un dialetto molto stretto, quasi incomprensibile. Quando nacquero le radio libere, insieme a Domenico Meo condussi per anni e con grande successo il  Canzoniere Agnonese, un programma di musica folk e poesie dialettali molto interattivo. Abbiamo anche combinato dei matrimoni per radio mettendo in contatto, in tempi in cui era difficile incontrarsi, innamorati che non riuscivano a comunicare».
Canzoniere Agnonese, un programma di musica folk e poesie dialettali molto interattivo. Abbiamo anche combinato dei matrimoni per radio mettendo in contatto, in tempi in cui era difficile incontrarsi, innamorati che non riuscivano a comunicare».
Hai usato il dialetto come strumento di lavoro, ma anche come raffinato mezzo letterario.
«Sono autore di poesie dialettali, ma soprattutto di tante opere teatrali. Come uomo di teatro nasco da attore della compagnia delle 4C di Giorgio Marcovecchio e Peppè De Martino, con cui ho interpretato più di dieci personaggi. Il passaggio alla regia, con circa venti rappresentazioni, mi ha permesso di curare meglio la gestualità e la presenza scenica».
Le tue trame si caratterizzano per la schiettezza, per le battute fulminanti e per l’umorismo salace.
«Lavoro molto sull’ironia ma mi interessa lanciare forti messaggi sociali su tematiche ambientali, sulla condizione degli anziani, sulla sanità, sull’educazione e sul rispetto tra le generazioni».
Hai mai pensato di scrivere in lingua italiana?
«No. Con il dialetto riesco a esprimermi meglio. Con una semplice espressione, con un determinato termine posso far capire molte più cose».
Siete stati più volte in tournée in Italia ma come fa chi non conosce il dialetto agnonese a seguire le vostre trame?
«Il gesto può sostituire il testo. Un critico teatrale mi ha confessato di non aver capito una parola di una rappresentazione ma di aver perfettamente afferrato il senso di quello che avveniva sulla scena. Poi quando recitiamo fuori Agnone raccomando agli attori di rallentare la dizione e italianizzando qualche termine. Abbiamo calcato i palcoscenici di tutto il Molise e l’Abruzzo. Non ho potuto partecipare alla famosa tournée canadese perché mi ero appena sposato e, mia moglie, mi chiese se preferivo fare il viaggio di nozze con lei o con altre 60 persone».
Hai difficoltà a reperire gli attori?
«Tutt’altro. Nonostante il grande impegno, il sacrificio, il tempo rubato alla famiglia ed al sonno durante i tre mesi di prove la comunità agnonese è molto ricca di persone delle più varie provenienze sociali e culturali che si offrono con disponibilità, abnegazione e senso di appartenenza».
Tra i titoli delle tue commedie: ‘La parentezza’, ‘La moglie in carriera’, ‘Nu sceur d vecchiaja’, ‘La croima d r merecul’, ‘Chi disprezza accatta’, sono tutto un programma. Da dove viene l’ispirazione?
«Dalla mia fantasia e dalla profonda conoscenza dell’umanità con la sua infinita varietà che ho acquisito stando per anni dietro il bancone. Riconosco al volo se ho di fronte furbi, furbastri, furbetti, gente umile e benevola, tipi particolari».
Ancora due capitoli della tua intensa esperienza di vita: la politica che ti ha visto più volte eletto nelle file del centro sinistra al Comune e assessore alla Comunità montana, ed infine la pallavolo.
«Ho cominciato a giocare a pallavolo spinto da mio fratello Stefano e anche grazie alle mie caratteristiche fisiche (202 centimetri di altezza e 105 centimetri di circonferenza toracica, 101 chilogrammi di peso) ho fatto parte della squadra agnonese che ha militato in serie D ed in C, animata e finanziata dall’ingegnere Sergio Iadanza, un grande e generoso appassionato. Con me giocavano Gabriele Amicarelli, Michele Barrasssi, Carlo Galasso, Daniele Cerimele e Giovanni Di Lollo, il mio alzatore preferito. Ricordo che una volta, a Carpinone, non era in forma, non mi dava la palla pulita e alle mie ripetute imprecazioni l’avversario che mi fronteggiava dall’altra parte della rete mi apostrofò così “Adesso basta, sono un sacerdote!” Si trattava del compianto don Mimì Fazioli. Dopo la morte di mio fratello smisi ma quando mio figlio Stefano volle passare dal karate alla pallavolo ho sentito un brivido. Stefano ha avuto una splendida carriera agonistica che lo ha visto giocare in serie A ed in Nazionale vincendo scudetti e Coppa Italia».
Una grande e meritata soddisfazione.
«Se parliamo di meriti lasciami dire che se dopo la morte di mio fratello sono stato capace di risalire la china e risollevare le condizioni economiche della famiglia devo ringraziare innanzitutto mia moglie Adriana che mi ha dato tre splendidi figli, la farmacista Marcella, Pasquale che è ingegnere e Stefano, il pallavolista che, se tutto va bene, potrà dare, al termine della sua carriera sportiva, un futuro al forno Patriarca».
Per concludere, mi puoi spiegare il tuo soprannome di famiglia, “D’erriupa candiune”?
«Tuo padre (Ercolino Marinelli, ndr) lo traduceva in inglese con il nome di un famoso complesso rock “The Rolling Stones”. Significa persona che smuove i macigni. Mio padre, come tutti i Patriarca, era un uomo molto alto e dotato di una grande forza fisica. Come il nonno faceva il carrettiere anche se nel 1954 comprese che i tempi erano cambiati e lasciò i cavalli per mettersi alla guida di un camion. Per farti capire quanto era possente, ti dico che una volta per stimolare un cavallo ‘falso’, che non spingeva a sufficienza un tiro a tre, gli tirò un pugno in testa con il risultato di ucciderlo sul colpo. Anche i Patriarca di Isola Liri hanno le stesse caratteristiche, ma lì li chiamano ‘ciampaliun’».
Italo Marinelli