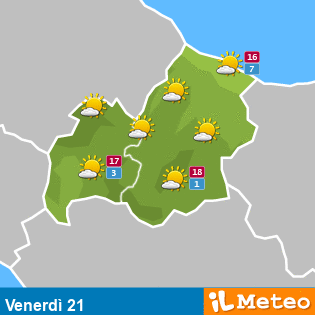Niente di nuovo sotto il sole. È proprio vero: spesso siamo condannati a ripetere gli errori del passato e a non trarne giovamento per uno sviluppo sociale e strettamente umano. «Ho avuto il Covid e non me ne vergogno». Una frase che non avrebbe motivo di esistere se solo avessimo imparato qualcosa dalla nostra storia recente e ancora attuale. «Ho avuto il Covid»: si sarebbe fermata qui l’affermazione di una giovanissima infermiera bojanese molto nota ed amata nel centro matesino, che opera e vive fuori regione da alcuni anni – in Emilia Romagna per l’esattezza – se solo avessimo appreso realmente qualcosa da quel Medioevo che ci limitiamo a dipingere come un periodo buio della storia, segregandolo ai limiti della comprensione umana e smarrendo, di fatto, lo scopo più intimo e profondo dello studio del nostro passato. «Non me ne vergogno perché ho svolto con onore il mio lavoro; mi sono ammalata facendo quello che amo, dedicandomi al prossimo» prosegue la ragazza che oggi svolge la sua attività di infermiera in un ospedale riabilitativo, col preciso compito di supportare i pazienti che hanno subito un intervento ortopedico o neurologico.
Nonostante qualcuno le abbia fatto avvertire un senso di emarginazione, come accadeva agli appestati nel XIV secolo, la giovane bojanese non si è lasciata scalfire e subito dopo la guarigione è tornata ‘in corsia’, al servizio di chi ne ha bisogno. «La clinica dove lavoro, in termini di pazienti e quindi a livello di patologie, è un po’ limitata – precisa -. Il nostro ospedale, privato e convenzionato, alla prima ondata si è fatto carico però di svuotare l’ospedale di Parma per liberare posti letto da dedicare al Covid. Si è registrato quindi sin da subito un forte aumento di pazienti e il lavoro sulle spalle degli infermieri si è amplificato notevolmente – rivela nell’intervista -. I colleghi che frequentavano la zona di Piacenza iniziavano a riferire dell’insorgenza del virus, e in concomitanza anche i nostri pazienti cominciavano a mostrare i sintomi tipici del Covid. Lo smarrimento e la novità iniziale ci spaventavano. Cominciò un vero e proprio assalto alle mascherine in dotazione al nostro reparto: unico vero dispositivo di protezione in quel momento. Continuavamo nella nostra attività quotidiana a tentoni, fino all’arrivo dei primi protocolli, ma l’incertezza regnava sovrana». La ragazza, visibilmente commossa al ricordo di quei primi momenti che oggi si stanno ripetendo quasi in maniera speculare, prosegue nel racconto e rivela come il carico di lavoro si sia letteralmente triplicato rispetto al normale. «Prima del Covid arrivavano in reparto pazienti pseudo-autonomi ma dopo l’esplosione del virus non lo erano più. I parenti potevano entrare solo uno alla volta e la sofferenza di non poterli vedere come invece avveniva precedenza è stata la causa di frustrazioni che sono ricadute sul personale, oberato peraltro da carichi di lavoro insostenibili. Anche alcuni di noi, poi, hanno cominciato ad ammalarsi. Io in primis. Ho avuto durante la prima ondata della pandemia tutti i sintomi riferibili al Covid. Sono stata sottoposta al tampone in forte ritardo, quando ero ormai guarita» afferma con gli occhi lucidi, perché qualcuno per questo motivo ha tentato di farla sentire ‘diversa’, anche se per fortuna ha potuto contare – e lo ha ribadito più volte – sull’affetto e l’aiuto del fidanzato e delle persone più care. «Un giorno mi si è sciolto il cuore nel vederle un paziente stringere la foto del figlio. Aveva la febbre molto alta, poche ore dopo ho cominciato ad avere mancamenti e difficoltà respiratorie. Il virus è subdolo e anche molto veloce –commenta -. I giorni successivi forti mal di testa e febbre: ho comunicato a chi di dovere la mia sintomatologia ed è iniziato la mia quarantena. Sono stata all’incirca un mese a casa. Per fortuna la tachipirina faceva effetto ma la paura è stata forte, anche di contagiare il mio compagno. Al tampone, dopo quasi un mese, sono risultata negativa, così ho ripreso il lavoro. Al mio rientro ho trovato procedure e protocolli cambiati: dovevamo gestire i pazienti colpiti e guariti dal Covid ma completamente dipendenti. Ragazzi giovani, ma anche 40-50enni, in pessime condizioni sanitarie. Tanti piangevano, afflitti dalla distanza dai familiari perché magari trasferiti nella struttura in una situazione di emergenza e tra uno spostamento e l’altro andavano spesso smarriti vestiti, telefoni, ricordi. Il semplice stargli accanto, parlargli, dargli ascolto poteva essere quindi di fondamentale importanza – ripercorre ancora la giovane bojanese -. Cercavamo tutti il modo per garantire quei minuti utili per confortarli. Vederli uscire con le proprie gambe è stata una delle soddisfazioni più grandi che ho mai vissuto finora, nella mia seppur breve carriera lavorativa. Il peso delle responsabilità è stato enorme, così come il carico di incertezze. La novità del momento ci ha sovrastati in quella prima fase rendendoci incapaci di affrontare la situazione. Ogni giorno sembrava di aver incassato una sconfitta. Doversi fermare per la malattia è stata una delle cose più dure che mi potessero accadere in quel periodo – conclude -, ma nonostante le difficoltà, le cose belle che quest’esperienza mi ha saputo donare mi rimarranno per sempre nel cuore». È passato quasi un anno eppure non sembra essere cambiato molto. C’è ancora tanto da lavorare, c’è ancora da lottare per sconfiggere questo mostro invisibile. La speranza – e lo si legge chiaramente nello sguardo giovane ma determinato della ragazza – è che il vaccino possa portare i risultati tanto attesi quanto prima e che si torni tutti insieme ad abbracciarci e a gioire come abbiamo sempre fatto prima che una mascherina o il distanziamento sociale ci tenessero così tremendamente lontani, seppure vicini.
R.G.